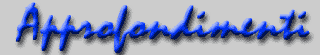| ENIO HOME PAGE | |
|
|
|
|
ILCASTELLO DI SABBIONARA D'AVIO
|
|
|
INIZI DELLA STORIA DI AVIO |
|
|
Secondo
alcuni studiosi di linguistica delle antiche popolazioni celtiche che
abitavano le zone alpine prima dell' arrivo dei Galli Cenomani, ai
quali si sarebbe debitori della storia più antica di Trento, Awi e
Brentoni non sarebbero nomi di centri abitati, ma indicazioni generiche
di popolazioni primitive; Awi significherebbe abitatori della palude, o
meglio delle ischie ( isolette ) del fondovalle; Brentoni invece abitatori
delle selve montane. Considerando che le genti antiche avevano poca
dimestichezza con le idee astratte ed il loro linguaggio si riferiva
evidentemente ai fatti concreti e quotidiani della loro vita, la
interpretazione dei due nomi mi sembra la più accettabile È noto
ancora che i Romani hanno conservato in genere le denominazioni dei
centri abitati preesistenti alla loro dominazione esempio chiaro è
Verona, nome gallo-celtico che significa la città
|
|
|
Moltissimi
dei più antichi castelli sorgono su precedenti posizioni fortificate
romane, che a loro volta spesso corrispondevano a originari insediamenti
preistorici. Il « castrum » in tempo di pace aveva il compito di
presidiare le vie su cui dovevano passare in tempo di guerre e di
perturbazioni le legioni militari, ed in tempo di pace il commercio e
gli scambi. Esso era sempre una posizione fortificata facilmente
difendibile anche da modesti presidi normali, attorno ai quali
vivevano gli artigiani del ferro e del legno, così importanti nella
vita militare, e c'erano il molino ed il forno per la cottura del pane.
In esso v' era poi il deposito del sale, così importante per la vita
dell'uomo e degli animali e per la conservazione dei cibi, talmente
importante che la paga del soldato romano si chiamava «salarium» (
cioè una razione di sale o quanto era sufficiente per procurarsela ).
Tutto il resto, grani, vino, legname, calce viva etc., doveva essere
prodotto in loco, ed ogni castrum doveva poter contare su una propria
autarchia economica. Anche il castello degli Awi corrisponde a questi
requisiti. Esso è posto su una 'collina sicura, inaccessibile agli
eventuali invasori, a guardia de]l'antica via che collegava Verona e la
pianura padana con Ala ed i territori meridionali del Trentino, ha
attorno a se una porzione di vallata dell' Adige assai ampia con
terreni fertili per la coltivazione dei grani (saraceno, frumento,
segale), colline per la produzione del vino e di olive, prati sulle
ischie che davano fieno e canapa per tessere la biancheria, e sulle
montagne sovrastanti pascoli per il bestiame e selve per il legname. Il
territorio è ridotto, ma per una guarnigione modesta attorniata dal suo
gruppo di famiglie esso era più che sufficiente. Caduto l'Impero romano
sopravvennero le popolazioni barbariche - goti, eruli, unni etc. -
che distrussero il distruggibile; giunsero infine i Longobardi che
passata la prima furia seguita alla conquista ed accortisi che di rapina
non si può vivere a lungo, misero un po d'ordine, rimettendo in sesto
quel minimo di organizzazione amministrativa, di cui le ridotte
popolazioni sopravvissute ai massacri avevano conservato il ricordo dai
tempi dei Romani, soprattutto per opera della Chiesa. Il monte Baldo in
tutta la sua estensione apparteneva allora a Verona, circoscrizione
della giudicaria prima di Sirmione e poi di Garda, e ne è chiara prova
la circoscrizione religiosa diocesana, che sopravvisse fino al 1796, che
ricalcava in genere le antiche suddivisioni amministrative di Roma. Gli
abitanti di Avio e di Brentonico, come ci appare chiaramente dal Placito
- cioè l'assemblea dei maggiorenti del ducato, - giudici e sculdasci
franchi e longobardi - tenuto a Trento nell'anno 845, mentre regnava
Clotario, secondo successore di Carlo Magno, per giudicare le legittime
pretese del Monastero (Xenodochio) di S. Maria in Organo di Verona,
dipendevano economicamente per quanto concerne la proprietà dei boschi
e dei fondi da detto Monastero, che era illegittimo erede del duca
Lupone di Verona, cui probabilmente la Signoria sul Monte Baldo era
pervenuta per investitura degli Imperatori Franchi. Peraltro sul piano
civile sia Avio, che Brentonico appartenevano al Ducato longobardo di
Trento, e perciò questo placito, che ne costituisce la prova storica,
si era tenuto in . questa sede. Dopo l'anno 845 vi è un periodo di
silenzio di almeno due secoli e per sentir riparlare di Avio dobbiamo
arrivare fino all'anno 1028, quando il monaco Gotschalk, benedettino
bavarese, aveva attreversato le Alpi ed era sceso fino a Verona per
ottenere alcune reliquie di S. Anastasia da quel Vescovo. Nel ritorno
egli era stato ospitato nel castelliere di Awi, che perciò a quel tempo
doveva essere abitato. |
|

Veduta dal basso del maniero IL CASTELLO DI SABBIONARA D'AVIO |
|
|
In
questi due secoli però erano successe tante cose spiacevoli. Ai
Longobardi, insediatisi anche tra noi, erano successi i Franchi de Baviera,
per cui Trento era entrato a far parte di questo ducato |
|
|
Interno del castello, particolare della cinta muriaria
OBBLIGHI DEI VICINI NEI RIGUARDI DEL CASTELLO |
|
|
Tutti
gli abitanti della giurisdizione avevano l'obbligo di fornire al
castello il legname e le opere necessarie per la sua manutenzione in
piena efficienza, nonchè il fieno necessario per il bestiame - cavalli
e muli - alla guarnigione ed al Vicario. Il Castellano inoltre aveva
diritto ad alcune regalie, soprattutto in bestiame e burro e gli era
riservata la pesca nel rivo dell'Acqua sagra. Gli Aviensi vi
provvedevano con il patrimonio comune delle Regole; tali obblighi
rimasero praticamente
in vigore fino all'epoca moderna e se ne discuteva ancora alla fine
del 1600. Se all'inizio essi erano stati accettati volonterosamente,
in quanto assunti in sede di costruzione del castello quale centro di
difesa delle popolazioni locali, che probabilmente dapprincipio
eleggevano i loro capitani e i custodi del castello, una volta divenuto
questo sede della Signoria civile e della relativa guarnigione
militare, del tribunale con relativo carcere annesso, nonché residenza
splendida relativamente alle dimore primitive dei nostri antenati, il
senso della cura del castello si era affievolito e l'onere era rimasto
tollerato come una imposta locale, e tutti sappiamo come siano amate e
gradite le tasse. Peraltro finché il Castello rimase sede militare
della potenza locale anche questi diritti e rispettivamente obblighi si
conservarono. |
|
| PASSAGGIO DEL CASTELLO AI CASTELBARCO | |
|
I
discendenti di Martino da Pergine tennero la Signoria del Castello
fino all'anno 1254, quando essi cedettero il loro feudo ai Castel Barco. Questa famiglia aveva già da almeno un secolo interessi ad A vio
e Brentonico, in quanto assuntrice delle decime dovute dai fedeli delle
sue Pievi al Vescovo di Verona, almeno secondo autorevoli fonti - dal
1155. Essi erano poi proprietari di Castel Barco (Chiusole ) e nel 1202
il Vescovo di Trento Corrado di Beseno li aveva investiti, in persona
di Briano, delle decime vescovili della terra di Ala, da sempre appartenuta alla diocesi trentina, e che si estendeva dal versante sud
del monte Zugna fino a S. Leonardo. Briano di Castel Barco si può
considerare il consolidatore della potenza Castro barcense nella VaI
Lagarina avendo trasformato le sue proprietà in feudi trasmissibili
in linea ereditaria, ma sottratti al libero commercio, unificando così
il dominio del suo casato da Aldeno fino ad Ossenigo e Belluno. Che il
centro del potere locale fosse il nostro castello risulta chiaramente
dal verbale di approvazione dello statuto della villa di
Dopo di allora il castello non fu più residenza dinastiale, ma vi abitarono sempre i capitani del castello, che probabilmente durante il periodo castro barcense avevano come loro dimora la cosiddetta casa del capitano, ( o dei soldati ) che ancora possiamo ammirare e che costituisce una testimonianza importantissima nella storia dell' arte medioevale veneto Iombarda. La Repubblica Veneta aveva fatto abbattere tutti i vari fortilizi dispersi nei vicariati - il forte di Và, quello di Serravalle, di Chizzola per concentrare le guarnigioni nei castelli di Sabbionara e di Dorso maggiore (Brentonico ) quest'ultimo incendiato e raso al suolo nel 1702 dai francesi di Vendom. |
|